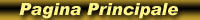|
Col termine "Tardo Impero" si designano i secoli calanti dell'Impero Romano, a indicare il caos del governo, onerato da spese di ogni genere, il declino dell'arte, le prime invasioni barbariche e per il nostro caso il deprezzamento e lo svilimento della moneta. |
|
Solitamente lo si riferisce al periodo successivo a Costantino ma per alcuni studiosi il termine si può riferire addirittura già agli anni dopo Marco Aurelio. La prima è un pezzo chiamato antoninianus introdotto nel 214, si riteneva valesse due denari ed era fuso in buono argento; esso riveste uno speciale interesse perchè la sua produzione rispecchia i problemi del III secolo. Travagliato da guerre e da spese sempre più alte, il governo presto lo svaluta: intorno al 270 fu coniato in rame con un sottile rivestimento d'argento. Gli antoniniani furono coniati sino al 300 circa, sono abbastanza facili da datare e caratteristici per la particolare corona a raggi portata dall'Imperatore ritratto. Alcuni pezzi portano anche dei segni di identificazione del luogo della coniazione, uso che poi sarà sviluppato in tutto il IV secolo. Questa moneta rispecchia anche altro: letteralmente dozzine di imperatori sono raffigurati sulle monete di questa serie, per lo più tra il 240 e il 290, la maggior parte di essi morti di morte violenta. In Gallia e in Italia Costantino II e Costante diedero effetto immediato alle damnationes memoriae e cessarono di battere moneta per Dalmazio. Costante emise nummi con la scritta secvritas rei pvb sul verso, come se lo Stato fosse appena scampato a qualche pericolo (Dalmazio e Giulio Costanzo o l’esercito ribelle?). Costantino II inaugurò immediatamente i nummi di bronzo con il recto in onore di Elena e Teodora, e dopo il suo arrivo a Sirmio convinse i fratelli a fare altrettanto Nel 395 l'Impero è diviso in due parti e per alcune decadi oguna di esse emette monete assolutamente identiche. Ma mentre la parte d'Occidente si estingue nel 476 la sua controparte d'Oriente sopravvive e rimane fiorente per parecchie centinaia di anni.* Con la decadenza dell'Impero si ridusse il commercio e di conseguenza Con la fine del dominio romano in Svizzera, nel corso del V sec. cessò l'afflusso di monete romane. La circolazione monetaria fu garantita ancora per qualche tempo dalle coniazioni già presenti, ma in seguito l'economia monetale tardoromana sparì quasi del tutto, e tornarono di regola il baratto e i pagamenti in natura. Nei regni barbari che seguirono l'Impero romano il sistema trimetallico fu abbandonato e le nuove coniazioni si limitarono alle sole monete auree, che a causa del loro elevato valore non erano però adatte all'uso quotidiano e probabilmente erano utilizzate prevalentemente per il pagamento dei tributi e per la tesaurizzazione. Dal 410, dopo il saccheggio di Roma da parte dei Visigoti di Alarico
* R. G. Doty |
|
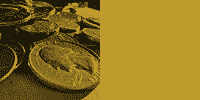

 Le monete del tardo Impero Romano
Le monete del tardo Impero Romano