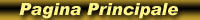|
|
La moneta d'eccellenza di Firenze fu il fiorino d'oro, la sua creazione un evento di Nel 1252 Firenze coniò i primi fiorini d'oro,
i quali ebbero subito un enorme successo e furono imitati in tutta l'Europa come simbolo di valore e di ricchezza, persino in Inghilterra, Germania, Ungheria e Russia. Nel nord erano
denominati gulden. Cambiò la misura, rimase però sempre identica l’iconografia: la moneta infatti mostra al diritto il giglio, simbolo di Firenze, e l’iscrizione Florentia e al rovescio il patrono san Giovanni Battista, circondato dall’iscrizione S. Iohannes. Per la sua bontà, e la bellezza salì in tanto pregio, e stima, che estinse ogni altra moneta d'oro, che per l'innanzi correva; e dando il suo nome a tutte l'altre che di conio elleno si fossero, divenne quasi moneta comune del Cristianesimo: ond'è che da grandissimi Re, e Principi in tutte le province fu battuto (Vettori, p. 1). Il nome fu attribuito a varie monete di Firenze con impresso il giglio, emblema della città. Nell’11° e 12° sec. i fiorini furono solo d’argento; nel novembre 1252 fu coniata la moneta d’oro (massa di 3,54 g e bontà di 24 carati) con i tipi di s. Giovanni Battista e del giglio. Per diversità di coniazione e di peso, ebbe denominazioni speciali nelle successive emissioni (largo, leggero, stretto, di grosso o buon peso, di suggello). Larghissimi il credito e la diffusione della moneta fiorentina, imitata ovunque e talora contraffatta; in Italia vi furono così il fiorino di Lucca, di Milano, papale o di camera, di Savoia ecc. 10. Firenze della prima metà del Trecento nella narrazione di Giovanni Villani [1] I banchi de' cambiatori erano da ottanta. La moneta dell'oro che si batteva era da trecentocinquanta migliaia di fiorini d'oro e talora quattrocentomila; e di danari da quattro piccioli l'uno si batteva l'anno circa ventimila libbre. Ancora nell'anno 2000 vi erano due nazioni europee le cui monete si chiamavano fiorino: Olanda e Ungheria. Le Goff nel suo libro"Lo sterco del diavolo" segnala come importante l'apparizione del fiorino ma senza darci il peso che merita; Mario Cipolla invece la segnala nei suoi scritti come una svolta epocale. Nonostante la sua enorme diffusione e fama in tutta Europa, al punto di definirla la "moneta della cristianità", il fiorino non ebbe successo in Africa e Asia, dove era molto più preferito il ducato veneziano. Si incorreva così in certi casi al limite dell'assurdo. Il primo "viaggio di levante" delle galee fiorentine ci illustra uno di questi incredibili aneddoti. Il 12 luglio 1422 partiva da Pisa la prima galea armata con destinazione Alessandria, alla quale se ne unì subito una seconda. Sulle navi viaggiavano anche più "merchanti fiorentini" i quali portavano drappi dal valore di 4mila fiorini e in contanti per acquisti di spezierie, 56mila ducati d'oro. Si noti la sproprozione tra il valore delle merci da vendere e il denaro da investire in compere. Quanto al fatto che si portassero ducati e non fiorini, i fiorentini dovettero accettare questa mortificazione perchè solo il ducato veneziano era ammesso ad Alessandria come moneta di scambio, e gli ambasciatori della Signoria, proprio fra le prime richiesta da rivolgere al sultano, dovevano domandare la parificazione del fiorino al ducato! Durante il pontificato di Giovanni XXII (1316 - 1334) la Camera Apostolica di Avignone introita
Nel Quattrocento la paga di un soldato mercenario italiano era in media di 3 fiorini al mese. Un destriero per i capitani o i connestabili costava almeno 50 fiorini mentre per i soldati ne bastava uno da 30 fiorini; talvolta lo si tollerava anche se di pregio inferiore ma, in questo caso, l'ufficiale pagatore si tratteneva un fiorino al mese sul soldo. Uno dei primi contratti conosciuti di assoldamento tra un sovrano e un condottiero dei mercenari è valutato in fiorini. Si tratta dell'accordo del 1 novembre 1448 tra Francesco Sforza e il marchese Guglielmo del Monferrato; quest'ultimo offre i propri servigi con 700 lance e 500 fanti per una ferma di 8 mesi, in cambio di uno stipendio mensile di 6600 fiorini. Nel 1420 il condottiero Braccio da Montone è assoldato dal papa Martino V per presidi nelle Marche di 300 lance e a Napoli di altre 800; in cambio riceverà 52.000 fiorni per i primi 18 mesi e altri 60.000 per i seguenti 18 mesi. Inoltre Braccio avrà 54.000 fiorini per mettere a disposizione altre 600 lance pronte ad intervenire nelle terre governate direttamente dal pontefice.* Il possesso di Livorno, quando Firenze lo acquistò da Genova, costò la bellezza di 100.000 fiorini. Dal 1530 il fiorino si vide affiancare lo scudo d’oro coniato sul modello dell’écu d’or au soleil francese che di lì a poco l’avrebbe soppiantato. Sopravvisse ancora dopo il 1533, quando ne fu abbandonata la coniazione, restando in circolazione in Italia e nel resto d’Europa per molti decenni. La fine delle emissioni dello storico e famosissimo fiorino a prima vista sembra un mistero o una assurdità. In realtà sembra ci fu dietro soprattutto una motivazione politica, un freddo calcolo per abbandonare quella moneta così legata alla civiltà borghese e repubblicana, alla grande età dei mercanti - banchieri, tanto da esserne diventata l'emblema. Sparirà all'instaurarsi del principato mediceo, il cui Duca Alessandro affiderà proprio alla moneta l'incarico di diffonfere la sua immagine di principe nuovo e l'inizio di una età diversa; per il suo ritratto nel testone d'argento chiamerà un'artista famoso, Benvenuto Cellini ed esso corrisponderà alle istanze più moderne della civiltà artistica contemporanea, col suo esplicito richiamo al più aulico, imperiale classicismo.** Dopo Alessandro, Cosimo metterà al bando la vecchia monetazione repubblicana,
Lord Vernon nelle sue Illustrazioni
ha raccolto « che il primo Fiorino fu coniato nel 1252
d’oro puro, e secondo il Villani, fu al titolo di ventiquattro carati e del peso d’un ottavo d’oncia. La
repubblica fiorentina durante i suoi maggiori infortuni, e fino agli ultimi anni della sua esistenza,
mantenne sempre il fiorino d’ oro della stessa bontà
e dello stesso peso. Al tempo di Dante i fiorini d’oro
erano sparsi e circolavano in tutti i paesi d’Europa, sulle coste di Barbarie, dell’Egitto e di Romania.
* Storia Illustrata- Luglio 1971 ** Beatrice Paolozzi Strozzi |
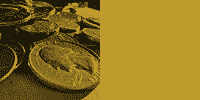

 Il fiorino: la moneta della Cristianità
Il fiorino: la moneta della Cristianità